Cartesio
René Descartes, noto anche in italiano come Cartesio, è una figura centrale nella storia della filosofia. Nato in Francia nel 1596, è universalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori del pensiero moderno. La filosofia di Cartesio rappresenta una svolta epocale, contraddistinta da un rigore metodologico e una chiara distinzione tra mente e corpo, che hanno avuto un impatto duraturo sulla filosofia, la scienza e la teologia.
Cartesio, in contrasto con gran parte della cultura del suo tempo, caratterizzata da uno scetticismo diffuso, abbracciava una visione intrinsecamente ottimistica riguardo all'impresa filosofica. Egli sosteneva con fermezza che la conquista del sapere non rappresentasse né un'impresa impossibile né una difficile, a patto che venissero seguite alcune regole fondamentali nell'indagine della verità, principalmente attraverso l'adozione di un idoneo metodo di ricerca. È importante notare che il suo lavoro "Il Discorso sul Metodo" porta il sottotitolo "Per ben condurre la propria ragione e cercare la verità nelle scienze," sottolineando l'approccio razionale che Cartesio propone.
All'inizio del Discorso, Cartesio mette in rilievo come il "buon senso," cioè la capacità di distinguere il vero dal falso e di avvicinarsi alla verità, sia "la cosa meglio distribuita nel mondo", in quanto presente in ogni essere umano.
Avendo stabilito che la ragione è uniforme per natura in tutti gli individui, Cartesio conclude che le diverse opinioni non derivano dalla superiorità di alcune persone in termini di ragione, ma piuttosto dalla diversità di pensiero e di oggetti di considerazione. Egli afferma che non è sufficiente possedere una buona intelligenza; ciò che è essenziale è la "corretta applicazione" di essa. Questo sottolinea l'importanza che Cartesio attribuisce alla ragione in relazione all'utilizzo pratico delle conoscenze e al progresso civile e materiale dell'umanità.
All'inizio del Discorso, Cartesio mette in rilievo come il "buon senso," cioè la capacità di distinguere il vero dal falso e di avvicinarsi alla verità, sia "la cosa meglio distribuita nel mondo", in quanto presente in ogni essere umano.
Avendo stabilito che la ragione è uniforme per natura in tutti gli individui, Cartesio conclude che le diverse opinioni non derivano dalla superiorità di alcune persone in termini di ragione, ma piuttosto dalla diversità di pensiero e di oggetti di considerazione. Egli afferma che non è sufficiente possedere una buona intelligenza; ciò che è essenziale è la "corretta applicazione" di essa. Questo sottolinea l'importanza che Cartesio attribuisce alla ragione in relazione all'utilizzo pratico delle conoscenze e al progresso civile e materiale dell'umanità.
Rivolgendoci ora all'importante questione delle regole da seguire nella ricerca della verità, seguiamo Cartesio mentre definisce le caratteristiche essenziali del "metodo," una parola che denota la "via" o il "sentiero" per raggiungere il traguardo desiderato, ovvero la verità:
Cartesio afferma che con il termine "metodo" intende regole certe e facili, le quali, se seguite con precisione, impediranno a chiunque di accettare il falso come vero. Senza affaticare la mente con sforzi inutili, ma piuttosto incrementando gradualmente la conoscenza, si arriverà alla vera comprensione di tutto ciò che è alla nostra portata. Questa definizione del metodo è tratta dalla sua opera giovanile "Regole per la guida dell'intelligenza" del 1628.
Cartesio osserva che l'aritmetica e la geometria, sebbene non ne abbiano fatto esplicito oggetto di discussione, già dispongono di un eccellente metodo. Questo è possibile poiché tali discipline si basano su oggetti chiaramente definiti e non ammettono affermazioni prive di rigorose dimostrazioni. Questo metodo fornisce una solida base per la definizione dei criteri che possono condurci alla verità anche in altri campi, specialmente in filosofia. Quindi, l'obiettivo è comprendere il processo matematico, generalizzarlo per renderlo applicabile anche ad altre discipline e, soprattutto, garantirgli una base solida.
Circa dieci anni dopo queste prime riflessioni, nel "Discorso sul Metodo," Cartesio enuncia le celebri regole del metodo, frutto di una vita dedicata allo studio e alla filosofia. Egli riflette sulla fortuna di aver intrapreso percorsi giovanili che lo hanno guidato verso considerazioni e massime da cui ha tratto un metodo per incrementare gradualmente la sua conoscenza, pur riconoscendo le limitazioni del suo ingegno e della sua breve vita.
Cartesio enuncia quattro regole fondamentali che, secondo lui, devono essere seguite da chi cerca la verità. La prima di queste regole è la "regola dell'evidenza," che prescrive di accettare come vero solo ciò che è evidentemente tale. In altre parole, questa regola invita a considerare come veri solo quei concetti o idee che sono chiari e distinti, ovvero quelli che la mente può percepire senza ambiguità, confusione o preconcetti. Cartesio considera chiarezza e distinzione come indicatori della verità. Un'idea è chiara quando è percepita in modo vivido e immediato, simile alla visione nitida di un oggetto. È così evidente che non può essere ignorata.
Per spiegare l'idea di chiarezza, Cartesio utilizza l'esempio del mal di denti, un'esperienza dolorosa ma evidentemente chiara per chi la sperimenta. Un'idea è distinta quando è separata da tutte le altre e può essere definita in modo autonomo. Anche se questi due concetti, chiarezza e distinzione, non sono del tutto identici, si influenzano reciprocamente. Un'idea distinta è anche chiara, e una chiara è distinta poiché è definita in modo preciso e non confusa con altre idee.
Con la "regola dell'evidenza," Cartesio condanna la tendenza comune delle persone a formulare giudizi precipitosi, creando preconcetti che impediscono il raggiungimento della verità. Il filosofo critica anche la cieca fiducia nelle credenze e l'obbedienza acritica all'autorità, che spinge molte persone a accettare le dottrine dei pensatori dell'antichità o delle tradizioni senza esaminarle con attenzione. Cartesio promuove l'uso della ragione e della chiarezza come strumenti per scoprire la verità, respingendo l'assunzione acritica e l'autorità come fonti di conoscenza.
Per spiegare l'idea di chiarezza, Cartesio utilizza l'esempio del mal di denti, un'esperienza dolorosa ma evidentemente chiara per chi la sperimenta. Un'idea è distinta quando è separata da tutte le altre e può essere definita in modo autonomo. Anche se questi due concetti, chiarezza e distinzione, non sono del tutto identici, si influenzano reciprocamente. Un'idea distinta è anche chiara, e una chiara è distinta poiché è definita in modo preciso e non confusa con altre idee.
Con la "regola dell'evidenza," Cartesio condanna la tendenza comune delle persone a formulare giudizi precipitosi, creando preconcetti che impediscono il raggiungimento della verità. Il filosofo critica anche la cieca fiducia nelle credenze e l'obbedienza acritica all'autorità, che spinge molte persone a accettare le dottrine dei pensatori dell'antichità o delle tradizioni senza esaminarle con attenzione. Cartesio promuove l'uso della ragione e della chiarezza come strumenti per scoprire la verità, respingendo l'assunzione acritica e l'autorità come fonti di conoscenza.
La seconda regola è la "regola dell'analisi," che suggerisce la suddivisione di ogni problema in parti elementari. Risolvendo ciascuna parte separatamente, si semplifica la soluzione complessiva del problema. La terza regola è la "regola della sintesi," che indica il passaggio dalla comprensione degli oggetti più semplici a quelli più complessi in modo graduale. Questo metodo presuppone che tutte le verità siano collegate tra loro, seguendo un ordine deduttivo-matematico.
La quarta regola è la "regola dell'enumerazione," che consiglia di effettuare enumerazioni complete e revisioni generali per garantire di non trascurare alcun dettaglio importante. Durante l'analisi, questa regola impedisce di dimenticare elementi essenziali, mentre durante la sintesi, evita di trascurare relazioni critiche tra le conoscenze.
Queste regole costituiscono il cuore del metodo cartesiano, concepito per conferire ordine e struttura al processo di ricerca della verità. Il metodo fornisce una base essenziale per l'indagine scientifica, sebbene da solo non possa garantire la certezza delle conoscenze o stabilire in modo definitivo la validità del sapere. Nella quarta parte del "Discorso sul Metodo," Cartesio affronta il problema della certezza e introduce il noto "metodo del dubbio," un approccio radicale alla ricerca della verità che ha suscitato notevole interesse e critica da parte degli studiosi.
La prima regola del metodo di Cartesio impone di accettare come vero solo ciò che appare evidentemente chiaro e distinto. Questo implica un atteggiamento di dubbio radicale verso tutto ciò che non soddisfa questa garanzia. Cartesio introduce il "dubbio metodico," una procedura rigorosa per valutare ciò che resiste al dubbio. Nel "Discorso sul Metodo," Cartesio scrive del suo desiderio di cercare la verità, iniziando col rifiutare tutto ciò di cui potesse dubitare. Questo lo portò a dubitare persino delle percezioni sensoriali, sospettando che i sensi occasionalmente lo ingannassero. Rifiutò anche argomenti matematici che aveva accettato in precedenza.
Nelle "Meditazioni metafisiche" quattro anni dopo, il dubbio si amplifica ulteriormente. Cartesio mette in dubbio l'intera realtà, partendo dalle percezioni sensoriali, in quanto i sensi occasionalmente inducono in errore. Allo stesso tempo, pone il dubbio sulla realtà del mondo esterno e perfino sulla sua stessa esistenza mentre è sveglio, suggerendo che potrebbe essere coinvolto in un sogno. Nonostante ciò, Cartesio riconosce che ci sono alcune conoscenze che devono essere considerate vere sia da svegli che in sogno, come le semplici e chiare verità dell'aritmetica e della geometria. Tuttavia, anche queste verità possono essere sottoposte al dubbio, in quanto potremmo essere ingannati da un "genio maligno" che altera la nostra percezione della realtà.
Il dubbio di Cartesio assume quindi una portata universale, spingendo la filosofia a cercare un fondamento indubitabile per la conoscenza. Questa ricerca per il "Cogito" diventa un punto di partenza cruciale nella filosofia cartesiana.
Nelle "Meditazioni metafisiche" quattro anni dopo, il dubbio si amplifica ulteriormente. Cartesio mette in dubbio l'intera realtà, partendo dalle percezioni sensoriali, in quanto i sensi occasionalmente inducono in errore. Allo stesso tempo, pone il dubbio sulla realtà del mondo esterno e perfino sulla sua stessa esistenza mentre è sveglio, suggerendo che potrebbe essere coinvolto in un sogno. Nonostante ciò, Cartesio riconosce che ci sono alcune conoscenze che devono essere considerate vere sia da svegli che in sogno, come le semplici e chiare verità dell'aritmetica e della geometria. Tuttavia, anche queste verità possono essere sottoposte al dubbio, in quanto potremmo essere ingannati da un "genio maligno" che altera la nostra percezione della realtà.
Il dubbio di Cartesio assume quindi una portata universale, spingendo la filosofia a cercare un fondamento indubitabile per la conoscenza. Questa ricerca per il "Cogito" diventa un punto di partenza cruciale nella filosofia cartesiana.


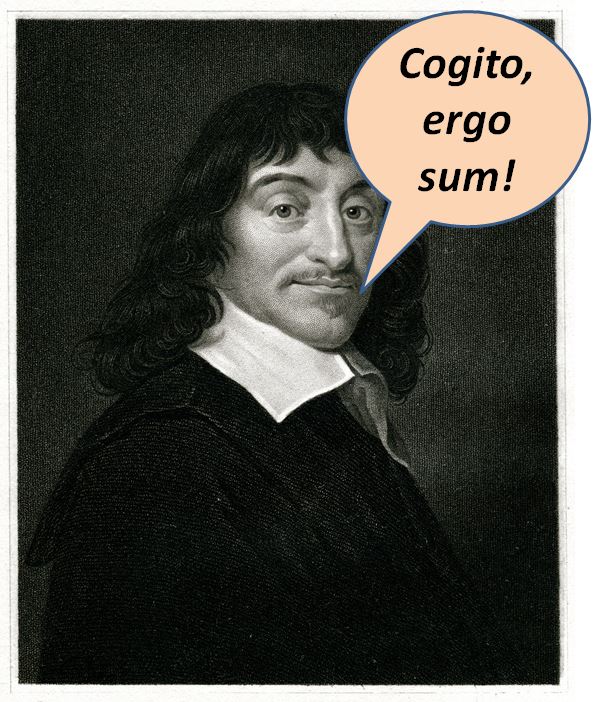
Commenti
Posta un commento